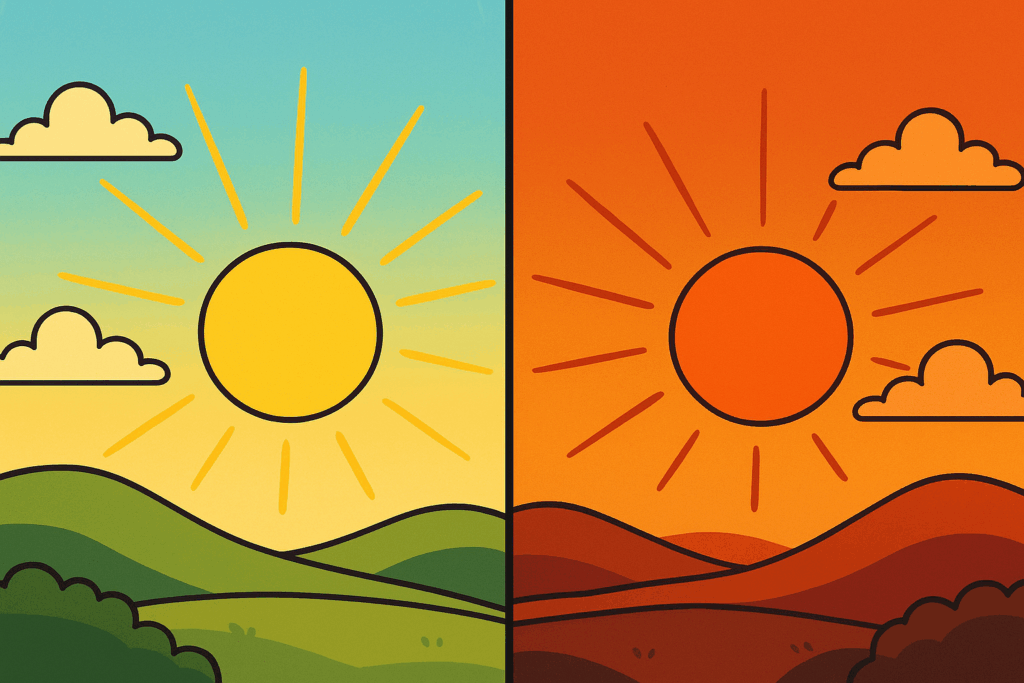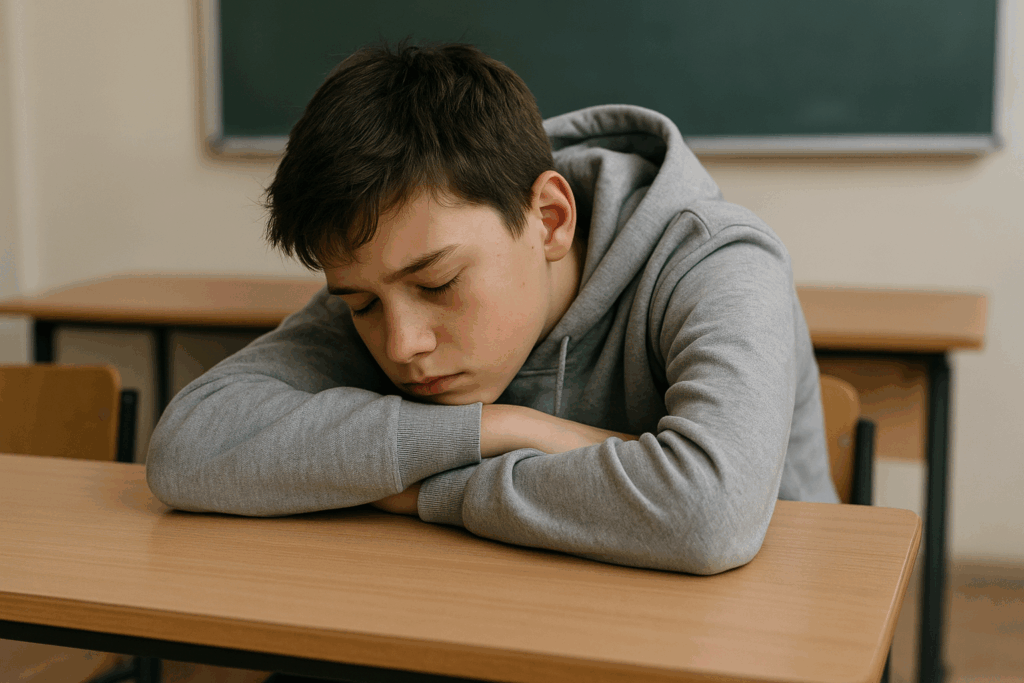Ci sono momenti che riempiono di senso il mio lavoro, momenti che sono come una boccata d’aria fresca in mezzo al puzzo di marciume stagnante che spesso appesta le nostre aule.
Ricordarsi che esistono spazi di riflessione e di incontro tra professioniste e professionisti della scuola e dell’educazione che hanno voglia, bisogno, di fare il proprio lavoro con cura e con una bussola etica, utopica, forte, fa bene all’animo ed è spesso difficile nella quotidianità della nostra scuola allo stremo.
Per questo tengo molto a queste righe che spendo più che volentieri, un po’ per aiutare chi, come me, è agli inizi di una carriera e sta ancora cercando il suo modo, le sue persone e le sue parole di riferimento, un po’ per ringraziare di cuore tutte le persone che sto incontrando e che stanno spendendosi per portare avanti un lavoro pregevole e importante.
Voglio citare al riguardo, prima di tutto, un percorso ancora in itinere e a cui è ancora possibile accedere:
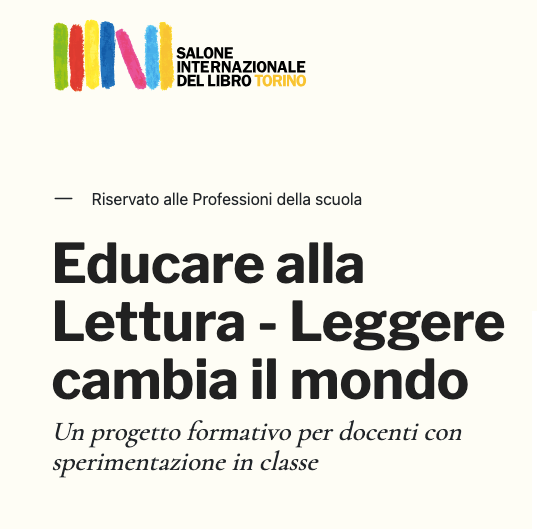
Il percorso di formazione Educare alla Lettura – Leggere cambia il mondo organizzato dal Salone del Libro di Torino, con Simone Giusti e Giusy Marchetta. Sentire parlare così chiaramente e così bene della lettura nelle classi, del suo significato formativo, delle criticità dell’accesso e dell’inclusione che la scelta del canone si porta dietro, con persone di grande spessore e profondità di pensiero, è un’esperienza che sento di consigliare a chiunque ami questo mestiere, prima di tutto per il piacere di farlo, in secondo luogo per la crescita professionale che porta. Per altro, vengono messi a disposizione dei kit didattici molto interessanti da poter sperimentare nella propria didattica.
Simone Giusti, Giusy Marchetta, Federico Batini, sono anche tra gli organizzatori di Le Storie Siamo Noi, convegno bellissimo che si è svolto a Torino qualche weekend fa sull’orientamento narrativo, che ha raccolto esperienze e ricerche che parlano di una scuola umana, di vita. Ragionamenti lontani dall’idea di una scuola-azienda dove ogni cosa sia spendibile sul mondo del lavoro, ma che parlano della potenza della riscrittura di sé come atto liberatorio, come atto emancipatorio.
La scuola che libera dalle catene della classe.
Questa è una scuola per la quale ha senso lottare, ha senso impazzire con i maledetti corsi abilitanti, ha senso stracciarsi le vesti per restare in classe, se la scuola può essere questo.
Dunque questo è un post di invito a quelle colleghe e a quei colleghi che faticano e arrancano nel pantano di ogni giorno e iniziano a chiedersi che senso ha.
Concediamoci ogni tanto uno di questi momenti, prendiamo aria e ricordiamoci perché lo stiamo facendo, che non siamo gli unici lì fuori che ci stanno provando.